Cristina Mian e Marco Frigerio sono una coppia di fotografi artisti che provengono rispettivamente dal mondo della pittura e della poesia. Hanno una visione molto lucida e profonda sull’arte, la loro attività fotografica e la filosofia dell’immagine, quindi più che un’intervista tradizionale questo è stato un dialogo pensato per fornire spunti per riflessioni, parlare di arte contemporanea e filosofia, ripercorrere il loro lavoro di qualche tempo fa Working Class, discutere della loro fotografia attuale, con la serie Side Effects, e accennare al progetto ancora in corso Corpo senza Organi.
Ne è risultata una lunga pagina, completa e esauriente sulla loro visione della fotografia, li ringrazio quindi in modo particolare per l’impegno e la passione dimostrate.
Fabiano Busdraghi: Esistono mille modi di fare fotografia, mille argomenti, mille stili, mille approcci e nessuno a priori migliore dell’altro.
Voi, almeno come punto di partenza, avete scelto un approccio che sembra diametralmente opposto al mio, quello della fotografia concettuale. In realtà poi nel seguito abbiamo trovato punti che invece sono, come diceva Marco qualche tempo fa, “pericolosamente vicini”. Mi pare infatti che sia io che voi siamo doppiamente interessati all’aspetto concettuale e espressivo, senza che una delle due componenti vada a sopraffare l’altra. Non parlo assolutamente dell’aspetto formale, della ricerca del bello, della foto estetizzante. Mi riferisco all’elemento puramente strutturale, del contenuto. Mi pare che sia io che voi siamo interessati tanto al messaggio razionale quanto alla componente emotiva. La differenza fra i nostri approcci mi pare che, banalizzando, sia schematizzabile in questo modo: io parto da uno stimolo espressivo, estetico, irrazionale, emotivo a cui poi accompagno un messaggio concettuale razionale, voi mi sembra che partiate piuttosto da un’idea intellettuale, un concetto puro, che esprimete arricchendolo con un impatto emotivo, una performance, un gesto diretto. I due metodi non appaiono più quindi come diametralmente opposti, ma piuttosto speculari e complementari.
Cristina Mian: Si, quello che dici è una corretta analisi del nostro approccio alla fotografia, in cui da una parte la componente concettuale ha una importanza primaria, veramente non mi ricordo nemmeno più dei tempi in cui ci comportavamo da fotografi “veri”, cioè andando in giro con la macchina fotografica a cercare “ispirazione”. Ora tutte le nostre immagini nascono a tavolino, nel soggiorno di casa nostra, mentre leggi un testo, ascolti una musica, ma dall’altra anche l’aspetto espressivo, emozionale, è importantissimo per noi, indissociabile da quello concettuale…non so dirti se questa natura “bifronte”, se questo doppio aspetto, sia legato al fatto che anche noi siamo “doppi”, nel senso che lavoriamo in coppia e quindi in qualche modo nella nostra fotografia c’è sempre una sommatoria di più pulsioni, di più aspetti, può darsi che sia così…se vogliamo semplificare sicuramente Marco è più sbilanciato sul versante concettuale ed io invece su quello espressivo, estetico, istintuale, sarà per la mia formazione pittorica.
Anche se in realtà la faccenda è più complessa ed è anche rivestita da ampie zone oscure, di pulsioni irrazionali, infatti l’idea del gesto diretto, del coinvolgimento nostro personale all’interno della scena, con il conseguente dischiudersi del nostro impianto emotivo, è di Marco e non mia.
Io quello che so è che non posso pensare la fotografia come staccata dalla vita, come lontana da un processo di ricerca strettamente connesso alla mia vita, come elemento motore di scoperte…
Marco Frigerio: E penso che il punto sia proprio questo, cioè per entrambi la fotografia rappresenta lo strumento privilegiato per operare una serie di scoperte a livello personale, e questo elemento, questa esigenza ineludibile di scoperta, è per me antecedente ad ogni aspetto concettuale, espressivo o formale, cioè informa e precede tutto quanto avverrà prima, durante e dopo lo scatto.
Devo però anche dire che tra me e Cristina ci possono essere delle differenze sul tipo di scoperte che ci prefiggiamo, ancora, semplificando un po’, ma giusto per capirci, per me dovrebbero sempre essere delle scoperte di ignoto, là dove l’ignoto è quella realtà che è tenuta nascosta dagli strumenti conoscitivi della nostra cultura.
Cristina invece può prospettare altri percorsi, però il miracolo che avviene sempre è che quando uno dei due individua uno scenario proficuo di sperimentazione e di scoperta, l’altro lo riconosce subito ed aderisce immediatamente al progetto, apportando ovviamente il proprio contributo ed il proprio pensiero, che inevitabilmente causa poi delle deviazioni dal progetto iniziale, in una specie di lavoro di accumulo di visioni, pulsioni, idee che ci portano spesso in territori che ci sorprendono, imprevisti ed imprevedibili, ancora delle scoperte appunto, seppur in un processo solo dialogico e di confronto, quindi assolutamente coerente con quanto poi ci aspettiamo dal processo più strettamente “fotografico”.
In tempi recenti poi si è aggiunto in noi un rinnovato interesse per le tematiche connesse al corpo ed alle possibili scoperte in ambito “corporale”, questo ci ha aperto nuovi ed inediti scenari, ed è uno dei motivi che ci hanno spinto ad entrare direttamente all’interno della scena ritratta, ad essere sia al di qua che al di là della macchina fotografica, a rischiare in prima persona e vivere sulla propria pelle le scoperte che ci siamo prefissi di fare, in una specie di forma ibrida tra performances, autoritratto e staged photography.
Anche se vorrei rimarcare che quando parliamo di staged photography non ci ispiriamo sicuramente né al neo-pittoricismo alla Gregory Crewdson e neppure ad un approccio alla La Chapelle o alla Erwin Olaf, quelle sono strade che non ci interessano più di tanto e che, personalmente, considero percorsi piuttosto sterili.
Quando parlo di staged photography in realtà è un modo inesatto per rendere più comprensibile il fatto che anche noi abbiamo l’esigenza di preparare ed approntare una scena, ma per noi questa esigenza è legata solo ed esclusivamente alla necessità di attuare un programma, un programma che si fonda sia su particolari condizioni iniziali di scatto o di utilizzo della macchina fotografica, sia su incidenti di scena programmati, su improvvisazioni legate a quegli stessi incidenti, in una parola sia su una pianificazione che sui possibili “sgambettamenti” di quella stessa pianificazione, ed è un programma che, una volta attuato, ci potrebbe portare poi a quelle scoperte di ignoto di cui abbiamo appena parlato (uso il condizionale perché potrebbe anche succedere che il programma non funzioni, che non porti a nessuna scoperta)…tutto il portfolio sugli effetti collaterali della televisione è stato realizzato partendo da questi presupposti, ed il nuovo lavoro sul Corpo senza Organi li porterà a conseguenze ancora più estreme…
Fabiano Busdraghi: Quello che dite è molto bello e mi trovate pienamente d’accordo. La produzione artistica non può essere indissociabile dalla mia vita, e la conseguenza più naturale e diretta, anche nel mio caso, è proprio quella di passare dall’altro lato della macchina.
In ogni caso mi sembra che per tutti e tre ci sia una certa stanchezza della fotografia e in generale dell’arte concettuale pura e dura, fatta di glaciale razionalità. Certo, ne riconosco l’importanza storica, ma ormai su quel fronte non si vede quasi niente di veramente rivoluzionario e interessante.
Uno dei motivi che personalmente mi allontanano dal concettuale puro per esempio è l’incomunicabilità dell’opera, la difficoltà di interpretazione e comprensione. Certo la fotografia, fra le tante cose, può essere anche linguaggio. Però la fotografia è un linguaggio pesantemente ambiguo e molto meno elastico della comunicazione verbale. Perché se si vuole fare del concettuale puro non si smette di fotografare e si scrive un libro di filosofia? Il mezzo non sarebbe più adeguato? Non si guadagnerebbe in chiarezza? Questo processo mi pare abbia portato buona parte dell’arte contemporanea a esercizio intellettuale elitario, relegandola a pochi addetti ai lavori.
Marco Frigerio: Se mi permetti vorrei rispondere a queste tue affermazioni, che condivido in gran parte, approfondendo alcuni concetti che abbiamo espresso prima, non è un modo per evitare un argomento spinoso, però così posso far capire chiaramente la nostra posizione nei confronti del concettuale e della nostra concezione dell’arte, ed implicitamente anche della fotografia, in generale.
Vedi, quando ho parlato della fotografia come strumento primario che ci permette di effettuare delle scoperte di ignoto, in realtà ho molto semplificato e, detta così, non permette neanche di capire pienamente l’impatto rivoluzionario e a volte devastante che la fotografia deve avere nelle nostre vite…confermo infatti quanto dice Cristina, è impossibile per noi pensare la fotografia fotografia come staccata dalla vita.
Prima cosa, che penso si capisca da quanto abbiamo già detto: per noi l’arte, la fotografia, non sono mai un fine a cui tendere, ma sono invece uno strumento per tracciare delle linee di vita, delle linee di fuga, delle deterritorializzazioni positive, dei divenire reali, che trasformano ed impattano e modificano le nostre vite, e questo perché questi divenire reali, queste linee di vita, introducono nuovi concatenamenti, nuove connessioni, simbiosi inaudite e nuovi orizzonti di senso, e per questo motivo, per questo essere uno strumento così strettamente legato con carne e sangue, queste scoperte di ignoto non si riterritorializzeranno poi più sull’arte, intesa ovviamente in questo caso come “struttura”, cioè significato condiviso e strumento di potere (alla pari di tutti i nostri “assoggettamenti”, quindi la cultura, lo Stato, l’Io, il significato, la morale, il viso, la famiglia), ma trascineranno invece l’arte e la fotografia verso le contrade dell’a-significante, dell’a-soggettivo, del senza-viso…
Cristina Mian: In una parola, quello che conta per noi non è l’arte, la fotografia, ma la linea di fuga, la linea di vita, il divenire reale che è stato tracciato attraverso lo strumento-arte, ed il problema dell’arte concettuale è che oggi non è più in grado di tracciare alcun divenire reale, perché oramai è stata inglobata e digerita e metabolizzata dal sistema dell’arte, dal sistema del potere, cioè da tutta una serie di linee rigide e conservatrici, quindi è diventata autoreferenziale, ridondante, è diventata struttura, élite, potere, cioè quanto di più lontano ci possa essere dalle nostre vite e dalle nostre esistenze…
Marco Frigerio: E se si condivide questo nostro punto di vista, è ovvio che l’arte, quella “vera” (termine bruttissimo ed ambiguo, ma così, giusto per capirci), quella che non è un fine ma un mezzo, deve sempre essere una linea di fuga, deve sempre essere motore di un divenire reale che è destabilizzante e distruttivo nei confronti del potere/struttura, e se così non fosse allora non sarebbe proprio nulla, ma sarebbe appunto solo ridondanza, consolatorio, decorativo, struttura, linea rigida, niente scoperte, niente visioni, solo assoggettamenti.
Cristina Mian: Tra l’altro lo stesso lo si potrebbe dire per alcune delle correnti fotografiche più in voga oggi che, una volta esaurita la loro carica “eversiva”, sono diventate veramente quanto di più noioso e ridondante io possa immaginare…non so, penso ad alcuni eredi (ma anche ad alcuni lavori recenti dei capiscuola), della cosidetta Scuola di Dusseldorf, cioè veramente non so più che farmene di questa fotografia che opera una catalogazione enciclopedica del reale, quando per me la fotografia, te lo dico alla Majakovskij, è come un martello che deve forgiare il reale, non “rispecchiarlo”…
Marco Frigerio: Però non possiamo eludere il fatto che la fotografia sia anche, nella sua intima natura, uno strumento di registrazione del reale, di documentazione dell’istante…e quello che quindi mi chiedo è, non si intravede forse uno strano parallelo tra la fotografia, la sua semplice immediatezza, il suo abbandonarsi all’istante, il suo potere di simbiosi con l’immediato, dicevo non si intravede forse una “assonanza” tra la fotografia e le linee di vita, di fuga e di divenire reale di cui ho parlato prima?
Non condividono forse entrambe alcune delle condizioni della loro stessa esistenza, cioè affidarsi appunto all’istante che muta, all’immediato svanire? D’altronde qualsiasi divenire reale è continuo mutamento, qualsiasi linea di vita è continua evoluzione in altro da sé…
Quello che poi questo significhi nella concezione e nella definizione della fotografia sinceramente ancora non lo so, però io e Cristina è tanto che inseguiamo l’idea di una fotografia che sia, da una parte un mezzo di divenire reale, motore di sperimentazioni e scoperte personali/corporali, una fotografia-mezzo e non fotografia-fine, cioè noi aspiriamo ad una immagine finale che sia ancora come un pennello che continui poi a “dipingere” nella vita, nella realtà, e non che sia un quadro “finito”, “autoriale” (e scusate il brutto paragone “pittorico”), e dall’altra ad una fotografia che funga anche da potente strumento di registrazione, anche “oggettivo” e documentaristico, perché no, che sia strumento di amplificazione perpetua, di queste linee di vita, di scoperta e di fuga…forse nessuna forma d’arte può fare meglio della fotografia queste due cose insieme…
Fabiano Busdraghi: Torno un attimo indietro per prendere spunto per la domanda successiva. Come dicevo mi sembra che buona parte dell’arte contemporanea sia chiusa nell’incomunicabilità, insomma, che non è necessaria solo una preparazione personale dell’artista, ma che proprio ci sia un problema di comunicazione. Se non si ha il libretto di istruzioni a portata di mano non si capisce niente del concerto. Se non si legge lo statement dell’artista si rimane completamente estranei al senso di una mostra.
Insomma, un’incomunicabilità che mi pare almeno parzialmente intrinseca e non solo dovuta alle limitazioni di chi ne fruisce.
Uno dei motivi per esempio per cui la vostra ultima serie sugli effetti collaterali mi piace più di Working class sulle fabbriche e la Cina proprio perché è più direttamente comunicativa. Alla fine il messaggio può passare più o meno distorto, verrà filtrato dallo spettatore, ma in ogni caso si instaura subito un gioco di complicità, ci si sente interpellati direttamente. Direi che è il riferimento al quotidiano, alla televisione che da più di mezzo secolo è accesa in tutte le case, questo oggetto che tutti conosciamo così bene. Insomma, in qualche modo sono fotografie che parlano un linguaggio cui siamo familiari.
Inoltre mi piace particolarmente il fatto che non date nessuna chiave moralista del vostro rapporto con la televisione. Dire che che la televisione fa schifo, che si perde troppo tempo a guardarla, che è un mezzo di controllo sulle masse, e via dicendo, è un po’ troppo semplice e qualunquista. Nel vostro caso semplicemente aprite una finestra sulle vostre interazioni con la televisione, senza esprimere giudizi. Più che portare risposte suggerite domande, un altro motivo per cui ci si sente direttamente in gioco di fronte alle vostre fotografie.
Cristina Mian: Hai colto perfettamente il senso di questa serie di immagini, è il più bel complimento che tu potessi farci.
Side Effects nasce proprio dall’esigenza di tracciare dei divenire reali, delle linee di vita, di fare delle scoperte a livello personale, confrontandoci con il mezzo televisivo senza alcuna intenzione di fare la morale a qualcuno o di ergerci su un piedistallo ed additare con un dito inquisitorio abitudini e comportamenti diffusi in tutte le case ed a tutti i livelli…molto semplicemente ci siamo messi in gioco in quanto utilizzatori, noi in primis, del mezzo televisivo, ed abbiamo voluto scoprire, fino in fondo, a livello personale, quali fossero gli effetti collaterali della televisione, quali concatenamenti si stabilivano se esposti per tante ore ad un programma, non c’è mai stata alcuna intenzione di esprimere giudizi ma solo la volontà di agire ed interagire, scoprire meglio qualcosa di noi stessi, anche senza nessuna “seriosità”, anzi devo anche dire che gli aspetti ludici ed autoironici hanno avuto un ruolo importante in questa serie di immagini…
Marco Frigerio: Tra l’altro in questa serie abbiamo cominciato a sperimentare con sempre maggiore consapevolezza, e a voler sempre più fortemente “contaminare” le immagini, con elementi, influenze, che arrivano direttamente da ambiti extra-fotografici, come le performances, così come è sempre più presente l’idea di attuare un vero e proprio programma, nel senso che abbiamo detto prima, cioè un programma che determini solo alcune condizioni iniziali di ripresa e di scatto, che fornisca alcune istruzioni operative per quanto riguarda gli elementi extra-fotografici, ma non possa prevedere quali saranno gli esiti dell’attuazione di questo programma, perché saranno influenzati anche da incidenti programmati e non, da improvvisazioni, da una pulsione irrefrenabile allo smarrimento, all’oblio, così come deve avvenire in ogni processo di divenire reale, in ogni processo di vera scoperta, e quindi non sarà mai possibile prevedere e controllare come sarà l’immagine finale, e questo non è importante, perché appunto quello che conta veramente è quello che accade nel tempo dello scatto, quali nuovi concatenamenti riusciamo ad instaurare quando questi divenire vengono tracciati…
Fabiano Busdraghi: Trovo appunto terribilmente interessante il fatto che entrate nelle vostre fotografie, che siete passati dalla rappresentazione esterna alla performance diretta. L’uscire da una sequenza puramente fotografica, una serie di azioni più o meno meccaniche e entrare in un “programma” i cui esiti sono completamente aperti. Potete approfondire ulteriormente che cosa rappresenta questa scelta per voi? Cosa significa porsi dall’altro lato della macchina fotografica?
Marco Frigerio: Oggi per noi significa prima di tutto manifestare ed accettare come evento ineluttabile, la necessità di essere affetti da tutto ciò che ci circonda, dagli oggetti, dalla luce, dal mezzo fotografico stesso, dalle persone…dal momento che la fotografia deve tracciare dei processi di divenire reali, delle linee di vita, l’unico modo per verificare se ciò accade realmente è quello di essere infettati, in prima persona, come in una epidemia pericolosa, da una selva infinita di concatenamenti, concatenamenti con azioni, persone, cose, pensieri…porsi davanti alla macchina fotografica è quindi sempre un modo per attuare un programma e verificarne sulla propria pelle i risultati, ma è anche uno smarrirsi, un avvicinarsi progressivo ad una soglia di indiscernibilità tra soggetto e oggetto, tra autore e opera, è un processo in cui poi quella che è spacciata è proprio la tua identità, il tuo essere Io, in qualche modo la tua autorialità (intesa anche come autorità e potere), sempre con il fine di effettuare delle scoperte di ignoto, di liberarti dei tuoi assoggettamenti, di forare e smantellare il muro bianco del significato.
Cristina Mian: Ovviamente il percorso che ci ha portato fino a qui parte molto da lontano ed è stata una lenta evoluzione, tutto però nasce dalla consapevolezza di nuove esigenze espressive.
Come tu ben sai noi abbiamo fotografato per molti anni seguendo un percorso sostanzialmente inserito nella tradizione della Scuola di Dusseldorf, i nostri riferimenti principali erano i Becher, Gursky, Struth, quindi un tipo di fotografia oggettiva, in qualche modo documentaristica, con una vocazione anatomo–classificatoria del reale.
Ad un certo punto però, ed è stato in coincidenza del lavoro sulla de-industrializzazione causata dall’entrata della Cina nel WTO, è stata forte in noi la necessità di avere un approccio più soggettivo, quindi non solo l’esigenza di una fotografia in cui le nostre emozioni, le nostre visioni, il nostro punto di vista, fosse chiaramente espresso, esperibile e percepibile, ma anche di una fotografia in cui noi fossimo direttamente coinvolti, in prima persona, nei fenomeni sociali ed economici che stavamo esplorando, una fotografia in cui ci fosse la possibilità di essere attraversati e soprattutto modificati dalla nostra ricerca, da quello che stavamo vivendo e sperimentando.
Poi il crescente interesse di entrambi per fotografi come Claude Cahun (che è stata una delle prime fotografe a mettersi dall’altro lato della macchina fotografica, anticipando di almeno 20 anni Cindy Sherman), oltre che il crescente interesse di Marco per gli Azionisti Viennesi e le performances più in generale, e quindi la volontà comune di cominciare ad introdurre ed “ibridare” con queste esperienze artistiche le nostre immagini, nonché un riavvicinamento di entrambi a tutte le tematiche legate al corpo, hanno fatto il resto e ci hanno portato dove siamo adesso…ad un certo punto il fatto di entrare direttamente nelle nostre composizioni era diventata per noi appunto una esigenza necessaria, ineluttabile ed ineludibile…
Fabiano Busdraghi: Per le vostre fotografie utilizzate unicamente il banco ottico. Uno strumento potente ma ingombrante insieme. In generale viene usato per sfruttare le possibilità espressive legate ai movimenti: correzione della prospettiva, selezioni dei piani di messa a fuoco, etc. Nel vostro caso, mi sembra, non usate nessun movimento, ma una inquadratura frontale e asettica. So che stampate in grande formato, e un negativo di formato adatto permette di ottenere stampe iperdettagliate e di grande presenza. Perché in questa serie queste caratteristiche sono espressivamente importanti? A parte nitidezza e dettaglio, che importanza ha l’uso del grande formato nel vostro lavoro?
Cristina Mian: Mah, se parliamo del lavoro sugli effetti collaterali della televisione sinceramente l’idea di utilizzare il banco ottico aveva, inizialmente, una motivazione molto pratica e tecnica.
Cioè, una volta stabilito che volevamo che tutte le inquadrature fossero frontali rispetto alla televisione, era altrettanto chiaro che in alcune immagini si sarebbe visto sullo schermo televisivo il riflesso della macchina fotografica o del fotografo, e l’utilizzo del banco ottico era l’unica strada percorribile per riprendere la scena frontalmente e non avere il riflesso del banco stesso nel televisore, sai come in quel “giochino” – esempio che trovi in tutti i libri sul grande formato, in cui c’è uno specchio che è ripreso frontalmente ma non c’è l’immagine riflessa del fotografo sulla sua superficie.
Poi però abbiamo capito che invece il riflesso del banco ottico, o di me stessa che opero sul banco, così come i riflessi dell’ambiente domestico in cui avvenivano gli scatti, sarebbero dovuti essere presenti e rappresentare una parte importante, fondante dello scatto e dei suoi esiti finali, perché erano uno strumento potentissimo per Marco per stabilire nuovi concatenamenti nel corso delle sue azioni, un modo per ampliare e rendere meno prevedibili gli effetti del suo interagire con l’immagine televisiva proiettata, e quindi questi riflessi sono entrati a far parte sia del programma che dell’immagine finale…
Marco Frigerio: A questo punto però le motivazioni di ordine pratico e tecnico per utilizzare il banco ottico sono andate a farsi friggere, anzi a voler ben vedere il banco ottico era forse il mezzo meno indicato per realizzare questo tipo di immagini, e quindi alla fine la nostra scelta si è basata su considerazioni puramente espressive e molto molto personali, non ultima anche la tendenza un po’ “suicida” a voler porre più limiti che si possono alla nostra fotografia, al nostro operare fotografico, come se nel limite ci fosse una forza propulsiva di liberazione di forze espressive che è sconosciuta quando si hanno tante, troppe opzioni, tanti, troppi strumenti di lavoro…poi guarda, a me personalmente l’affermazione che bisogna usare lo “strumento giusto” mi ha sempre fatto venire l’orticaria, preferisco di gran lunga utilizzare, quando possibile, lo “strumento sbagliato”…ho sempre poi come fortissima la tentazione a privilegiare sempre l’idea e la sua immediatezza, la sua urgenza di spontaneità, cioè per me l’ideale sarebbe che quando ho una idea io la possa realizzare subito, utilizzando quello che ho intorno al momento, anche se poi capirai che non è così, questa urgenza viene sempre “tradita” dal pensiero, dalla riflessione, dal confronto tra me e Cristina, però secondo me questa pulsione rimane comunque come sedimentata sul fondo del nostro agire, informa sempre, in qualche modo, le nostre decisioni finali…
Vabbè dai, permettimi queste piccole provocazioni, però quello che dico è profondamente radicato nel nostro modo di rapportarci alla fotografia, anche se per la serie “Side effects” alla scelta definitiva del banco ci siamo arrivati, come dicevo prima, per gradi, per confronto, per riflessione, per tutta una serie di urgenze espressive.
A dirti la verità, una volta capito che i riflessi di Cristina e dell’ambiente domestico dovevano rappresentare momenti fondanti, propulsori di divenire e concatenamenti nella fase di scatto, le prime prove le abbiamo effettuate con una reflex digitale, perché questo ci diceva il buonsenso, perché quello era lo strumento giusto per questo tipo di lavoro (dico reflex digitale perché era quella che abbiamo utilizzato per le prove, la scelta finale poteva anche essere una 35mm argentica piuttosto che il medio formato).
Però una volta visti i primi scatti con la reflex abbiamo subito capito che c’era qualcosa che non andava, il fatto che fosse lo strumento giusto per quel tipo di immagini, che ci restituisse e ci immergesse in un flusso di lavoro “corretto” (a livello di tempi di esposizione, possibilità di lavorare in luce controllata visualizzando subito i risultati, velocità e facilità operativa, giusto per citarne alcuni) ci impediva, di fatto, di applicare il nostro programma nei modi e nei termini in cui stava prendendo lentamente forma.
Perché in noi invece era sempre più forte l’esigenza di lavorare sempre in luce ambiente, di avere tempi di esposizione superiori ai 30 secondi così da permettermi di interagire a lungo con l’immagine trasmessa dal televisore, di specchiarmi nei riflessi di Cristina e dell’ambiente domestico, di essere tutti attraversati, in un tempo così lungo di scatto, da ogni sorta di incidente, di imprevisto (programmato e non), di improvvisazione, di smemoramento.
Ed era anche forte l’esigenza di essere obbligati alla lentezza ed alla macchinosità operativa del banco ottico, non solo per le affermazioni sul fatto di imporsi dei limiti che abbiamo fatto prima, ma come a rimarcare, in questo eccesso di “presenza” operativa del banco, anche l’importanza della sua immagine riflessa nello schermo televisivo in quanto fondante di quel processo di divenire reali che stavamo cercando di attuare… insomma per noi era prioritario e necessario stabilire tutta una serie di concatenamenti tra l’immagine televisiva, me stesso, i riflessi di Cristina e dell’ambiente domestico, le condizioni di scatto, il mezzo utilizzato per lo scatto, gli oggetti “trovati”, gli incidenti di percorso, perché è solo attraverso questi concatenamenti, alcuni dei quali imprevisti ed imprevedibili (si riveleranno solo durante le mie azioni), che il nostro programma poteva essere attuato, e solo con un banco ottico è possibile raggiungere una tale livello di necessarietà, di asfissia, di stretta correlazione, di organicità, ma anche di indiscernibilità di tutti gli elementi del concatenamento…
Cristina Mian: Senza considerare che per noi era importantissimo anche essere ciechi, di essere al buio, di agire nell’oblio, era importantissimo darsi una volta per tutte nel corso dello scatto, e quindi tutti gli strumenti di lavoro digitale, che ti permettono di visualizzare subito il risultato, erano stati subito scartati dopo le prime prove.
Ed ancora, cosa c’è di più “buio” di un banco ottico, in cui tutto avviene in un certo senso al buio, dal caricamento delle pellicole negli chassis a quando metti lo chassis nel dorso e da quel momento non puoi più visualizzare l’immagine sul vetro smerigliato…
Fabiano Busdraghi: Approfondiamo questo concetto dello strumento sbagliato e del buio. In generale tendete a limitare le vostre possibilità e lavorare all’interno di un percorso ben determinato.
Utilizzare un unico formato, oppure un solo obiettivo, un certo tipo di ritocco con Photoshop, uno schema di luci, un soggetto ben preciso. È un approccio con cui mi riconosco completamente per quanto riguarda il materiale, dove vagare da un corpo macchina all’altro, cercare l’obiettivo sempre più performante, la soluzione a tutti i nostri mali, in genere nasconde l’incapacità di utilizzare quello che si ha fra le mani per fare fotografia. Per quanto riguarda soggetti, tecniche, approcci cerco di contenermi per non essere eccessivamente dispersivo, ma so bene che sono un eterno irrequieto, con tutti i pregi e difetti che questo mio modo di essere si porta dietro.
Cosa significa per voi questa scelte di porsi dei limiti? Mi pare che ci sia un implicito sforzo di scavare il più possibile uno strumento, un soggetto, una tecnica, insomma, stabilire dei confini precisi e cercare di dare il meglio di se stessi su un argomento strettamente coerente. Giusto?
Marco Frigerio: Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, in parte ti abbiamo già risposto prima, quando ho detto che nell’imporci dei limiti troviamo una forza propulsiva di liberazione di forze espressive che è spesso impossibile quando si hanno tante, troppe opzioni, così come ribadisco che fondamentalmente è in noi fortissima la tentazione a privilegiare sempre l’idea e la sua immediatezza, la sua urgenza di spontaneità, quindi siamo come spinti istintivamente a realizzarla con quello che abbiamo intorno, e se quello che abbiamo intorno è solo un banco ottico 8×10” ed un 300 mm. beh, allora molto semplicemente usiamo quelli, anche se questo vuol dire scostarsi dall’idea o costringerci a percorrere strade impreviste, ma penso che in quello “scostamento” ed in quelle “strade impreviste” ci sia anche molto del senso del nostro lavoro…poi sai, permettimi un po’ di leggerezza e di sana autocritica, io ci metterei anche il fattore pigrizia, a volte ci atterrisce l’idea di acquistare un nuovo sistema e tutto quello che questo comporta, tra cui anche investire tempo ed energie per imparare ad utilizzarlo da un punto di vista tecnico, anziché invece investire questo tempo e queste energie per quello che ci interessa maggiormente, cioè la nostra ricerca e la nostra fotografia, per cui torniamo un po’ a quello che dicevi tu, cioè conoscere molto bene il proprio mezzo di lavoro ed imporsi dei limiti ben precisi, nel nostro caso per esempio lavorare solo con un obiettivo, significa anche potersi permettere di concentrarsi solo sugli aspetti espressivi e spingersi paradossalmente oltre ai limiti, quantomeno in questo comparto.
Alla fine direi che i fattori che influenzano le nostre scelte sono molti, come vedi, però quello che posso sicuramente dire è che in questa ricerca, a volte forse un po’ eccessiva, nell’imporsi dei limiti, e che ci ha tenuto fino ad oggi ben ancorati nel grande formato, non ci sentiamo però minimamente legati in modo dogmatico a nessun mezzo in particolare, così come non vogliamo essere i paladini di nessuna guerra santa di superiorità di un sistema rispetto ad un altro, che ne so argentico contro digitale, e questo perché abbiamo la consapevolezza che, qualsiasi siano le ragioni per cui decidiamo di utilizzare l’8×10” anziché una compattina, sono ragioni strettamente legate al nostro modo di intendere la fotografia, sono ragioni molto personali ed anche molto utilitaristiche, cioè strettamente funzionali ai nostri personalissimi progetti, e quindi non hanno nessun valore al di fuori della nostra coppia…così come siamo sempre ben consapevoli che, per il prossimo progetto, potremmo tranquillamente cambiare tutto, esattamente per le stesse ragioni per cui fino ad oggi abbiamo utilizzato solo il grande formato, e dopo tante “limitazioni” auto-imposte vogliamo quantomeno tenerci bene stretta questa “libertà”, anche se come avrai capito, tutto sommato, la libertà la detestiamo…e passami anche questa provocazione…
Fabiano Busdraghi: Figurati, su Camera Obscura questo genere di provocazioni, i punti di vista scomodi, sono tutti ben accetti. Per finire ecco l’ultima domanda: la storia dell’arte è curiosamente costellata da coppie per la vita e la fotografia. In genere le opere prodotte sono diverse da quelle di un collettivo di artisti. Quando si entra in contatto col lavoro di marito e moglie fotografi si ha l’impressione che siano un tutt’uno fotografico. Che cosa significa per voi lavorare a due? Come ripartite i compiti?
Cristina Mian: La fase teorica, la fase preparatoria del portfolio, quella in cui decidiamo su cosa lavorare e come realizzare le immagini, solitamente è frutto di una stretta collaborazione e di un confronto costante di idee, intuizioni, visioni.
Generalmente ad uno due viene l’idea per un nuovo portfolio e la comunica all’altro, e da quel momento cominciano discussioni e riflessioni serratissime, fino a che, di comune accordo, decidiamo se attuare o no il progetto che, per via di questo confronto, può subire anche alcuni mutamenti rispetto alle intenzioni iniziali.
Ad ad essere sincera negli ultimi anni le idee sono sempre arrivate da ambiti molto lontani dalla fotografia, principalmente la filosofia e la poesia, che sono gli ambiti di studio di Marco, è il caso ad esempio del prossimo lavoro sul Corpo senza Organi che è stato ispirato dalla lettura di Antonin Artaud e di Gilles Deleuze e Felix Guattari, a volte invece attingiamo dalla pittura, che è invece più vicina alle mie corde, anche se però devo ammettere che anche le influenze pittoriche vengono in qualche modo “filtrate” dalla lettura di saggi di critica, piuttosto che di trattati di filosofia.
Nella fase di scatto invece i ruoli, da un punto di vista tecnico, sono molto ben definiti: io mi occupo della composizione, dell’utilizzo del banco ottico, della “regia” della scena nel caso ce ne fosse bisogno.
Marco invece, per quanto riguarda l’ambito tecnico, si occupa solo delle rilevazioni esposimetriche, e questo perché mentre io sono impegnata ad armeggiare con il banco lui, essendo l’attore principale delle composizioni e delle azioni che introduciamo nelle nostre immagini, comincia a tessere una forma di “rapporto” con l‘ambiente, con le condizioni di scatto, fa una prima verifica sulla sua pelle delle regole di attuazione del programma.
Comunque posso anticipare che abbiamo deciso che anche io entrerò in prima persona nelle nostre immagini, anche io sarò parte attiva nella creazione di concatenamenti e di processi di divenire reale, nel prossimo lavoro sul Corpo senza Organi vedrete sicuramente anche me…
Marco Frigerio: E comunque per noi lavorare in due fa parte ancora di quel processo continuo di volontà di “sgambettamento” e tradimento delle intenzioni, delle azioni, per accedere a territori imprevisti ed inauditi, fa parte della nostra avversione per l’idea di autorialità intesa come autorità individuale, questa nostra simbiosi è ancora uno smarrirsi, un modo per essere affetti uno dall’altra ed affidarsi all’oblio, a quella forma di indiscernibilità in cui si cessa di essere soggetto, si cessa di essere senso, si cessa di essere un Io ma si è finalmente una moltitudine affollata, una muta, una infezione nella selva dei concatenamenti…
Cristina Mian e Marco Frigerio
Cristina Mian (nata nel 1967) e Marco Frigerio (nato nel 1966), sono moglie e marito, formano quindi una coppia sia nella vita che nella fotografia.
Lavorano principalmente con macchine fotografiche a grande formato, 4×5″ (10x12cm) e 8×10″ (20x25cm), e curano personalmente le stampe delle loro immagini utilizzando stampanti digitali inkjet di grande formato e uno scanner a tamburo per scansire i negativi di grande formato. La loro formazione artistica ha origine nella poesia e nella pittura, poi in anni recenti hanno scoperto la fotografia ed è stato l’inizio di una inarrestabile e divorante passione, tanto che oggi si dedicano esclusivamente a questa forma di espressione artistica.
Il sito con i loro lavori fotografici è raggiungibile all’indirizzo: www.cristinamian.com.
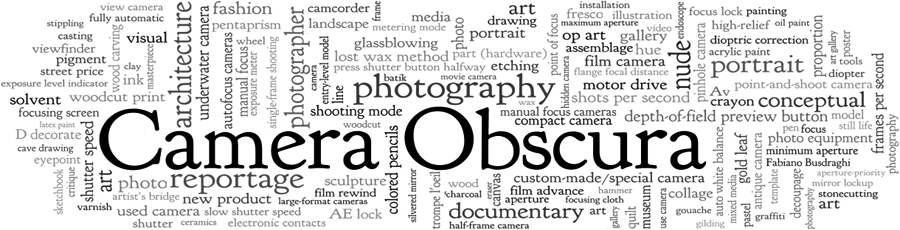




























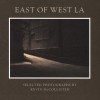






Puoi anche iscriverti al feed RSS dei commenti a questo articolo.