Una storia su Canning Town, Londra, UK. Reportage realizzato nell’agosto 2012 da Elettra Paolinelli.
Internauta alla continua ricerca di oggetti di mio interesse, come oggi si fa rovistando tra le informazioni multimediali ricercate su Google, Youtube e Facebook, ho cercato nel mondo.
Manovich sostiene che il mondo oggi sia una raccolta infinita e destrutturata di immagini, testi e altri record di dati; ed è nel mondo che ho trovato il database per raccontare una storia, una storia che narrasse l’assenza, una storia a proposito del vuoto, una storia che descrivesse la mancanza.
Questa è la storia di un “gap”, una storia sull’alienazione.
Vivevo a Londra, precisamente a Canning Town, ad Est della City.
Ogni sera tornavo a casa stanca e con gli occhi rossi, come me, frotte di pendolari si accalcavano sulla metro gremita, affollando lo spazio claustrofobico. Alla fermata “Canning Town” scendevano quasi tutti, e lì il flusso prepotente di uomini e donne si biforcava. Molti prendevano la mia strada, ma nessuno si parlava; tutti continuavano a camminare a passo spedito quasi ci fosse qualcuno ad inseguirli o stesse cominciando a piovere; ognuno a viso abbassato, molti con le cuffie alle orecchie. A volte incrociavo gli occhi stanchi di quegli abitanti-zombie, e quell’istante fugace mi faceva scorgere per un attimo la loro anima triste; alcuni consumavano bevande in piedi, avvicinandosi alla fermata del bus, altri chiaccheravano al cellulare o leggevano il giornale della sera, ma nessuno mi parlava mai. Quella massa multiforme di persone si disperdeva tra le viuzze, entravano dentro abitazioni sudate di umido, e venivano ingoiati da ascensori che sembravano serpenti famelici, ma nessuno si salutava, nessuno accennava un sorriso, nessuno si conosceva.
Nella strada verso casa respiravo l’odore acre delle ciminiere vicine, sentivo lo sfrigolio dei cavi elettrici sulla mia testa, e le sneakers ai miei piedi grattavano l’asfalto ritmiche, vedevo le finestre illuminate e sagome di persone che si muovevano all’interno di quei rettangoli luminosi, quasi fossero fotografie in movimento, ma erano tutti soli, sempre.
Vedevo micro-storie, micro-mondi dispersi in un magma di confusione e desolazione, vedevo esseri umani tristi e soli e incapaci di intessere relazioni, ognuno nel suo guscio, la sua piccola “monade”, la propria stanza.
La memoria che ho di questi luoghi e che ho cercato di raccontare attraverso il mezzo fotografico è una memoria grossolana, cruda e crudele, memore solo di cio che è a dismisura d’uomo, memore solo del caos di quelle notti calme, di quei luoghi paradosso, luoghi in cui il silenzio è sordità.
La mia percezione di questo quartiere si legava al concetto di violenza tenera, di angoscia tranquilla, di urlo silenzioso.
Come potevo raccontare tutto questo? La fotografia diventò così il mio unico strumento di narrazione di una quotidianità esasperata, disperata.
L’impressione visiva che Canning Town mi dava di se stessa, era di un luogo frammentario e disgregato, senza strutture, un pastone omogeneo di singolarità locali, distribuite casualmente.
Essa era per me assimilabile a una discarica opaca, impenetrabile allo sguardo, un luogo del caos, dove le tracce si confondevano, corpi e indizi scomparivano.
Solo la fotografia fermava per me gli unici attimi di senso, in questo panorama liquido e magmatico.
Di giorno ripercorrevo i luoghi di Canning Town secondo una modalità ondivaga, che tuttavia andava costruendo una sovrapposizione di storie, una stratificazione di vite ed eventi che diventavano mano a mano leggibili grazie alla rilettura di questi in chiave fotografica.
Questa “Londra oltre i confini” andava prima di tutto percepita, respirata, vissuta, e solo in un secondo momento raccontata per mezzo di fotografie.
Solo vivendo questi luoghi riuscivo a comprendere a pieno la loro anima, la loro essenza, la loro storia, bloccandoli in “frame” per mezzo delle mie fotografie, quasi si trattasse di un film che io avevo bisogno di bloccare per comprendere, digerire, vedere, discernere.
Il racconto diventava sempre piu intimo ed intento a ricercare le ragioni alienanti nei comportamenti piu semplici, quotidiani e radicati, nelle pieghe nascoste e insospettate delle storie umane.
Mi aggiravo con la mia macchina fotografica tra le stradine e i cavalcavia, le zone residenziali e i grattacieli, cercando un’omogeneità impossibile e documentando l’urbanistica fantasiosa, l’abbandono delle aree comuni, l’edificazione di fortezze private.
In questo quartiere nessuno era vicino di nessuno, e ogni casa, ogni persona era una singola entità disgregata dal contesto; nessuno si conosceva e tutti accuratamente si evitavano l’un l’altro. Ogni casa esibiva almeno due o tre grosse antenne paraboliche, quasi fossero bandiere pirata da sventolare sui tetti e qualcuno aveva murato addirittura le finestre dei piani inferiori. Di cosa avevano paura? Questo quartiere-dormitorio di giorno si trasformava in un quartiere fantasma dove rare apparizioni umane scandivano il mio lento peregrinare. Le persone si guardavano i piedi, guardavano i messaggi sul proprio Blackberry, ma non si guardavano mai attorno. Io invece mi fermavo, guardavo le case, le strade vuote e scattavo fotografie, avevo come l’impressione di essere la prima a rivolgere l’attenzione a quei luoghi di periferia. Mi sentivo come un’esploratrice che campiona per la prima volta la giungla vergine e come tale cercavo di capire le abitudini dei suoi abitanti, usi e costumi di un popolo così diverso da me. Ma ogni sforzo di comprensione era vano, ogni contatto bruscamente interrotto.
In questo rumore ottico in cui le relazioni scomparivano ed assieme ad esse il contesto si dissolveva, in questo spazio senza memoria in cui tutti i fenomeni diventavano virtuali, pensai che era inutile cercare un senso, perchè in esso si generavano significati fantasma, pure allucinazioni, causate dall’inerzia percettiva.
L’atto del fotografare diventava così sempre più un atto di documentazione, e mi appellavo con urgenza sempre maggiore alla potenza mostratrice della fotografia, a quella sua capacità congenita di additare la realtà, di dire solamente “Hic et Nunc”.
Non volevo dare un’interpretazione a ciò che vedevo, volevo solo dire: “Questo è quello che sta succedendo qui e ora”. Mi appellavo all’inconscio tecnologico di Vaccari, eppure la mia anima essendo lì presente non poteva che influenzare i miei scatti. Come secondo i principi della meccanica quantistica l’osservatore influenza l’esperimento, così nei miei scatti c’era molto più “me” di quanto volessi. Tuttavia quel modo di fare e intendere la fotografia, forse il più primordiale, quello che si illudeva di catturare la pura e semplice realtà, e che invece proponeva personalissime visioni, è forse da considerarsi oggi il più efficace per descivere una realtà, uno stato d’animo, una situazione in essere per cui è difficile trovare le parole.
Nel mio reportage, quando le parole risultarono fallaci nel descrivere la realtà, la pura immagine fotografica divenne per me l’unico mezzo possibile di narrazione del reale.
Testo e fotografie di Elettra Paolinelli.
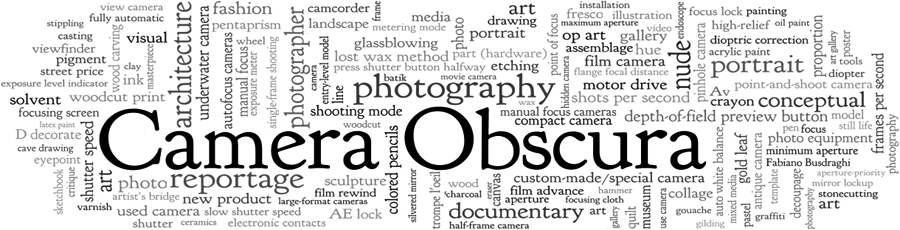






































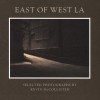






Spazi vuoti e silenziosi nella loro eloquenza, che non hanno bisogno di rumori, di parole, di musica, di suoni e di commenti perche´a loro modo raccontano la loro storia, fatta di fermi immagine che bloccano una realta´mai ferma, sempre in divenire ma apparentemente immobile e sempre uguale a se´stessa. Mi piacciono queste foto perche´mi mostrano una citta´normale, gente normale, che tace perche´e´stanca, perche´non ha piu´niente da dire a causa del troppo fare. Mi piacciono queste foto sorde, immobili, immutabili, alcune simili a vecchi dagherrotipi che nemmeno il tempo scalfisce. Mi piace l´idea che la foto torni a quello che era, un attimo di tempo e non sempre piu´simile a un filmato, sempre piu´”movimentata”. Mi piacciono perche´vedo il tentativo di mostrare una realta´quale essa e´, non di fare del realismo a tutti i costi, inserendo il divenire laddove, per forza di cose, la stasi e´regina incontrastata.
Mi piacciono perche´finalmente il pensiero non si esplicita in linguaggio, in spiegazione, in interpretazione.
Mi piacciono perche´nel loro silenzio mi permettono di usare solo un senso, la vista, e di scegliere se parteciparvi o rimanervi al di fuori, come una bambola ipnotizzata.
Puoi anche iscriverti al feed RSS dei commenti a questo articolo.