
© Nobuyoshi Araki
– Che splendida immagine, peccato che non sia una fotografia!
Questa è una frase che si sente pronunciare spesso, a proposito dei lavori di tanti artisti contemporanei che mischiano con disinvoltura diverse pratiche più o meno fotografiche, utilizzano la fotografia come punto di partenza per elaborazioni anche molto lontane dello scatto di partenza. Con l’avvento del digitale è una frase pronunciata anche da tantissimi stampatori della vecchia scuola di fronte ad una fotografia che è stata ritoccata al computer in modo evidente. In generale è una frase pronunciata con un’accezione negativa, quando non si sfocia nel vero e proprio sprezzo.
Un atteggiamento di questo genere implica sempre una certa dose di presunzione. Intanto significa che esista una certa definizione universale della fotografia, e che sia nota a chi ha pronunciato la frase. Naturalmente in generale quella che è considerata La Fotografia è esattamente il genere coltivato dal nostro interlocutore, che si auto investe del merito di essere un rappresentante della Vera Fotografia, una specie di messia di una classe sacerdotale investito di illuminazione divina, che deve battersi contro il paganesimo imperante nel mondo.
Spesso chi pronuncia questa frase afferma quindi implicitamente due cose:
- che esiste una categoria assoluta, che gode di caratteristiche universali, che determina cosa sia “la vera fotografia”
- che tutte le pratiche che differiscono da questa categoria assoluta non sono strettamente fotografiche.

© Joel Peter Witkin
Nel secondo caso si tratta dell’innato rifiuto dell’uomo per tutto ciò che è diverso, estraneo alle regole costituite. È l’atteggiamento reazionario di chi crede di aver tutto compreso e che l’ultima parola sia stata detta. È l’atteggiamento di chi in fondo ritiene di aver sempre ragione. La voglia di bollare quello che non è diverso come estraneo e pericoloso. È un atteggiamento vecchio come la storia dell’umanità, ma per fortuna ovunque e in ogni epoca, oltre alle spinte reazionarie, sono sempre state presenti anche quelle rivoluzionarie, che hanno permesso al mondo di non fossilizzarsi in pratiche ortodosse e pregiudizi. Chiunque esprime un giudizio dettato dallo sdegno su una pratica fotografica che non conosce o non condivide dovrebbe quindi considerare che così facendo sta dichiarando se stare dalla parte dei sacerdoti o dietro alle barricate.
Che questo atteggiamento di rifiuto per il diverso sia irrazionale e spesso deleterio mi sembra abbastanza evidente. Più complesso invece il discorso per quanto riguarda l’esistenza di una definizione univoca dell’ambito fotografico. Nei prossimi giorni pubblicherò quindi una serie di articoli che cercano di determinare se è possibile dare una definizione di fotografia che valga tanto sul piano astratto che su quello concreto, una definizione che sia razionale e teorica ma allo stesso tempo adatta praticamente alle peculiarità del media, una definizione che valga tanto per i filosofi che per i fotografi.
Visto che, al di là delle definizioni, si va a parare sui rapporti fra la fotografia e la realtà, virando sul valore informativo o documentario della fotografia, questa serie di articoli ha un titolo un po’ pomposo: fotografia e verità.

© Emily Allchurch
Vedremo come cercando di dare una definizione univoca si ricade sempre sempre in categorie troppo ampie o troppo strette per essere corrette dal punto di vista filosofico e allo stesso tempo adatte al senso comune e ad un uso concreto della parola fotografia. Forse conviene allora rinunciare a definire univocamente il fotografico e come consequenza accettare apertamente ogni forma di contaminazione piuttosto che arrogarsi il merito di fare fotografia e tacciare tutto il resto con un semplice “ma questa non è una fotografia”.
In realtà non si tratta solo di determinare se la fotografia è difinibile o meno, ma di un ambito più vasto. Quello che è in gioco in ultima analisi è il rapporto fra realtà e rappresentazione. Per questo questi articoli si chiameranno “fotografia e verità”.
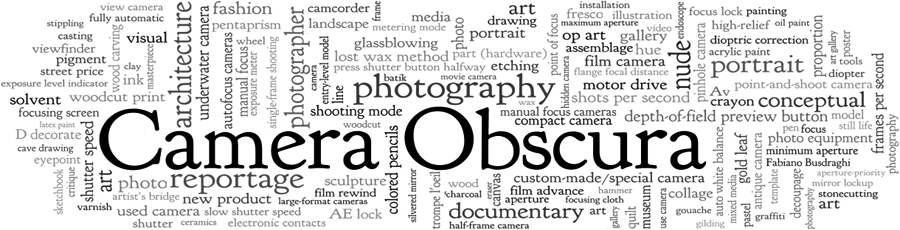

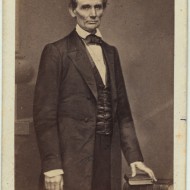











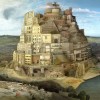

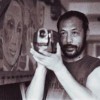











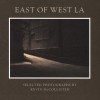






potrei ribattere: quale verità?
http://www.artonweb.it/fotografia/articolo1.htm
Ciao, e grazie mille per la segnalazione di quest’ottimo articolo.
Dopo attenta lettura, l’unica cosa su cui mi sento di ribattere è il fatto che il digitale abbia fondamentalmente cambiato le carte in gioco, che oggi più che mai la fotografia menta.
Direi che la continuità con il passato è fortissima, il digitale ha semplicemente reso infinitamente più veloce e relativamente più facile la manipolazione delle immagini. Ma in termini di possibilità, le tecniche analogiche aprivano almeno altrettante porte, se non forse ancora di più.
In ogni caso, al di là di questo, è proprio la fotografia in sé ad essere intrinsecamente mistificazione della realtà. Che sia digitale o analogica alla fine poco importa.
“L’intensità dell’immagine é la misura della negazione della realtà, e dell’invenzione di un’altra scena. Trasformare un oggetto in immagine vuol dire sottrarre, una ad una, tutte le sue dimensioni: il peso, il rilievo, il profumo, la profondità, il tempo, la continuità, il senso. A prezzo di questa spoliazione, l’immagine acquista una tale potenza di fascinazione da diventare medium della pura obiettività, da cui traspare una forma di seduzione più sottile”. (Jean Baudrillard).
Come dire che, una volta fotografata, l’immagine della realtà diviene essa stessa l’unica realtà esistente.
Al proposito mi viene in mente un aneddoto: durante una conversazione con Picasso, un signore tirò fuori dalla tasca una foto della propria moglie e gliela mostrò dicendo “vede, questa è mia moglie, è un’immagine molto fedele, lei è proprio così” . “Bene – rispose Picasso – vedo che sua moglie è molto sottile ed alta 10 cm …..”
Appunto.
Ottima citazione e bellissimo aneddotto! Grazie mille per il commento veramente ad hoc 🙂
ho leggiucchiato i tuoi articoli… sembra che il tuo scopo sia voler ridefinire la fotografia attraverso i contesti in cui si manifesta decontestualizzarla ogni volta. forse li devo leggere meglio. Io forse non ho mezzi per comprendere fino in fondo il tuo pensiero Fabiano, ma trovo a volte ozioso il tuo modo di procedere per questa strada. Ho iniziato ad interessarmi al fenomeno fotografico per caso, e come primo approccio l’ho subito considerato un mezzo. E’ il mezzo prediletto dai detentori del potere per indirizzare le masse, per creare un senso comune, e anche far percepire un tipo di realtà. Mi sono quindi interessato al meccanismo del potere non al mezzo fotografico in sé. Poi per capirlo meglio ho cominciato a fotografare. Ma ho sempre mantenuto un occhio critico verso questa pratica. Ti parlo della mia esperienza non perché è esemplare ma perché definisce i miei limiti interpretativi. Per farla breve la fotografia diventava per me una sorta di vizio, un hobby a tempo pieno. Considerando il mercato e la tecnologia sempre in evoluzione in ambito fotografico, intuisco che la fotografia non solo è il mezzo prediletto dal potere ma è anche un affare economico in sé. Creare immagini è un bisogno primario dell’uomo contemporaneo. come afferma rosalind Krauss le foto sembrano essere più vicine a delle tracce o indizi, che a delle icone, senza voler approfondire certe argomentazioni, non è un bisogno primario avere una fotocamera, ma se ci si pensa bene noi potremmo fare a meno anche di frigoriferi e lavatrici, ma nel nostro quotidiano li consideriamo vitali, parte della nostra realtà. Io sinceramente faccio fatica a immaginarmi una realtà senza fotografia, ma posso benissimo immaginare un mondo fantastico senza fotografia.
ciao
Ciao Marco,
lo scopo di questi vecchi articoli era per metà didattico, per metà reazione esasperata per tutti quei fotografi che giravano nei forum online pontificando contro il ben minimo intervento di ritocco, perché secondo loro questo priverebbe l’immagine dello status di “vera fotografia”.
Insomma, non volevo filosofeggiare, visto anche che discussioni di questo tipo sono già state approfondite anni fa, semplicemente mettere online una serie di articoli facili per mostrare come la storia della fotografia è in realtà la storia di mille fotografie, non di una fantomatica “vera fotografia”.
Consiglio la lettura del libro di Michele Smargiassi: “Un’ autentica bugia. La fotografia, il vero, il falso”.
Credo che nessuna scoperta umana sia stata accolta senza resistenza da parte dei soliti benpensanti; di coloro, cioè, che poco sanno e nulla vogliono sapere; perché il nuovo comporta la fatica di studiare, di rimettersi in ballo, allontanandosi da quei quattro concetti che hanno faticato ad apprendere e solo per questo sono vangelo.
Costoro riescono a definire reale quello che racconta una fotografia bidimensionale, in B/N, tagliata soggettivamente dal fotografo in ripresa, modificata nella prospettiva da varie focali che appiattiscono e deformano, e ritoccata in camera oscura, in fine art, da un estraneo stampatore, ecc.
Costoro non sanno che la Legge non riconosce la fotografia come prova primaria; perché variazioni di colore (viraggi), fotomontaggi, pseudorilievo e trucchi di ogni genere sono nati in analogico, più di cento anni fa. Il fotografo, in camera chiara o in camera oscura, “cerca” in qualche modo di ripristinare “il presunto reale” che egli “crede” fosse presente in scena al momento dello scatto. Ovviamente se fotografo e stampatore coincidono. Altrimenti lo stampatore recita a soggetto.
Ben detto! Grazie mille del commento che precisa benissimo le intenzioni dell’articolo.
Puoi anche iscriverti al feed RSS dei commenti a questo articolo.