Ricapito quasi per caso su un testo scritto nella primavera del 2004, subito dopo aver assistito ad un incontro con Marc Riboud.
Nonostante il mio candore nei confronti della mostra, delle fotografie e della qualità delle stampe, le pagine che riportano alcuni spezzoni della conferenza rimangono per molti versi interessanti e attuali. Marc Riboud è un autore che ho sempre profondamente stimato, le cui parole semplici e schiette furono una splendida lezione di fotografia e di vita che continuo a ripetermi ancora oggi. Ho allora deciso di pubblicare il testo nella sua interezza.
Sono le cinque del pomeriggio. Ho finito una grossa parte di programmazione e dovrei cominciare un nuovo capitolo. Chiudo la mia sessione Linux con qualche ora d’anticipo, ed esco all’aria aperta.
C’è un sole appena velato, ma dopo le piogge intense dei giorni passati è una rinascita. Fa caldo. Le parigine con il loro fascino elegante e la pelle chiara delle gambe nude ti mettono qualcosa di pesante in mezzo al petto, che non riesci a mandar giù.
Prendo il 67, ma c’è traffico e riscendo subito, tanto la Maison Européenne de la Photographie non è lontana. Tutti i mercoledì fra le 17 e le 20 l’accesso è gratuito. L’altro giorno ho letto su À nous Paris, uno di qui giornali che ti danno gratis nel metro, che c’è una retrospettiva su Marc Riboud e un incontro con l’autore alle sei.
La MEP è in una strada tranquilla e assolata del Marais. All’ingresso c’è un giardino zen di soli ciottoli di pietra. La metà sinistra tutti bianchi e a destra nero antracite, con una lunga linea morbida che fa da confine fra i due colori, onde e monticelli che serpeggiano intorno. Un giardino per la meditazione, dice la didascalia.
La mostra è grande e completa. Cento o duecento fotografie nei formati più diversi, dal piccolo quadratino che ti devi chinare per guardare, alla gigantografia un metro per due. Tantissime foto degli anni 50, 60 e 70 e poi via via fino alle contemporanee.
Moltissime in oriente, con soggetti fantastici e irrepetibili. Poi quelle note di sempre, la ragazza che accarezza la margherita contro le baionette, Le peintre de la tour Eiffel… un reportage inedito su Leeds, definita la città più triste d’Inghilterra, con foto fumose di ciminiere e case di mattoni tutte uguali, strade vuote e desolate. Robert Capa consigliò Riboud di andare in Inghilterra per incontrare ragazze e imparare l’inglese, egli -a suo dire-, non fece né l’una né l’altra cosa, ma ritornò con centinaia di foto. Appresa la morte di Capa, al suo ritorno dall’Inghilterra le smarrì e dimenticò. Sono state ritrovate la scorsa estate, cinquanta anni dopo, chiuse in una scatola.
Una buona percentuale sono tirages d’epoca. Come è noto la carta conteneva molto più argento di quella moderna, e si riusciva ad ottenere un nero più profondo e intenso. Le stampe infatti sono incredibili, le zone d’ombra sono ampie e intense, eppure si notano i particolari e i dettagli, non sono mai piatte. Poi, qua e là, emergono illuminati i volti, le mani, i soggetti della composizione, come nei dipinti antichi, che sono tutti scuri e neri ma i volti sono illuminati dalla luce di una finestra o una candela e sembra che sia una strana divinità a dare risalto al gioco di forme ed espressioni.
Non riesco a capire come fa ad avere delle foto tanto contrastate, dove la luce scolpisce solo ed esclusivamente i centri di interesse e lascia tutto il resto a intessere atmosfera, ad avvolgere e creare lo sfondo su cui risaltare. Sono spessissimo foto scattate con scarsissima luce, in interni, con fortissimi contrasti, ma le luci non sono mai bruciate e le ombre mai piatte. Sembrano quadri, acquarelli o stampe. E tutte gridano. Hanno un contenuto e un messaggio eccezionale, non puoi restare indifferente, ti colpiscono in pieno, anche se non sai guardare.
Mi fanno voglia di buttare la mia OM2 nella Senna e dedicarmi ad altro, che tanto non vale la pena.
L’auditorium è in leggera penombra, con lunghi drappi porpora che scendono fino al suolo e comode poltrone imbottite. Seduti insieme alla scrivania il vecchio fotografo e la ragazza che lo deve intervistare.
Lei sui trent’anni, capelli ramati di chiara tintura, occhiali, rossetto pesante. Parla con voce monotona e usando grandi parole che faccio un po’ fatica a capire, perché i francesi non le usano mai. Si vede che ha studiato e si è imparata a memoria la lezione, in ogni dettaglio. Conosce le date e gli eventi, i luoghi e le pubblicazioni, cita con competenza.
Lui è vecchio come un nonno, con una capigliatura candida e luminosa. Le mani gli tremano visibilmente e non so come faccia a scattare ancora foto, quando si versa da bere rovescia quasi l’acqua. Comincia le frasi e non sa troppo come finirle, è un po’ sordo e rallentato, disteso, spontaneo. Si vede che è un seduttore, che è galante e corteggiatore. È simpatico e spiritoso, fa un sacco di battute acute e tutti nella sala sorridono. Ci tiene in pugno.
Lei pone le sue domande complicate, quasi inopportune, impudenti. Lui fa un’espressione buffa di stupore.
-Mah, vede… un fotografo responsabile? la responsabilità è questione di giustizia… gli architetti, i medici… la mia vita è stata un lungo divertirsi, qu’ai-je fait depuis soixante-dix ans sinon m’amuser ?
Ma lei insiste, cita premi e riconoscenze. Un fotografo del suo calibro non può riassumere la sua grande opera come un puro e semplice divertissement.
-I libri premiati, si… me ne sono dimenticato due mesi dopo, mai avrei pensato che quarant’anni dopo se ne sarebbe parlato ancora, qui con lei… ma come fa a ricordarsene? Si, ho avuto un vago diploma, tipo quelli della scuola, che bien evidentemente ho perso chissà dove…
Racconta della scuola quando ci andava ancora lui, di come gli inflissero una punizione di otto giorni e come la cosa lo colpì molto più profondamente della premiazione di cui stiamo parlando. Ma la rossa non ci crede, come è possibile che uno si diverta a fare foto e basta? Come si può vivere senza tutto il suo rigore intellettualoide, senza le parola altisonanti di stupore e ammirazione che un’opera sublime infonde nel suo spirito estasiato? Senza le teorie che imparato nella sua accademia? Ci deve per forza essere una ricerca di identità, di scopi, di stili, di ingegno…
-Ma no, non si cerca, non si cerca mai. Le genti che sono alla ricerca di qualcosa finiscono per non trovare niente. Semplicemente si cammina, si cammina e si cammina, forgiando l’occhio. Il francese ha voglia di mettere dappertutto termini intellettuali, ma l’occhio non è fatto per pensare. L’occhio è fatto per guardare.
Ma lei non accetta la frecciatina. E insiste, con la sua ricerca estenuante.
-Guardi che è come se lei pretende di analizzare l’amore. Com’è stato, meglio prima, meglio dopo… così si distrugge tutto. Perde tutta la poesia signorina. Poi dopo a uno non gli piace più. Smette di farlo…
Finalmente lei si da un attimo per vinta, e per una rara volta Marc Riboud non scuote la testa alla domanda. Si ripercorrono i viaggi e i luoghi. Lui riesce a incantarti con quello che ha visto, una Cina a tinte scure, degradata, povera. Sei seduto sulla tua comoda sedia e sogni della prostituzione, la criminalità, la corruzione. I giovani che tirano i risciò a piedi nudi, la pioggia che cade, i quartieri poveri.
-Per gli uomini il pericolo è come le belles filles, ça attire.
E poi si dilunga sul suo modo di fotografare e intendere la fotografia, che condivido in pieno. Con semplicità e umiltà. Spiega come non c’è il paese o il viaggio, ma il modo di vedere che è importante. Come e perché ci si esercita? Nessuno lo può dire. È l’istante che conta, l’istante che è importante. In fotografia non si fa altro che acchiappare gli istanti, anche nei paesaggi, che poi il vento cambia, e il sole se ne va. Una foto non è mai la verità, ma pertanto è presa da un istante della realtà. Il tempo, il modo di guardare, l’inconscio, è questo che detta poco a poco lo stile. Bisogna coltivare l’inconscio per vedere. Si parte sempre dall’architettura dell’immagine, la forma, la composizione, le linee, la prospettiva. Si cerca di comporre una storia, la propria storia, in un’architettura fantastica ma spontanea.
L’occhio non è fatto per pensare.
Spontanea? non si deve pensare? La tipa si lancia in una altisonante tiritera sui massimi sistemi, l’arte e la filosofia… Lui la placca al volo:
– Ma che fa, sta recitando una poesia?
Ormai lei è finita, lui la prende in giro senza pietà, con gentilezza e spirito, ma le dice tutto in faccia, le fa notare che è lei che ha le idee preconcette ma non lui, una persona che semplicemente se ne va in giro passeggiando e facendo foto delle cose belle, proprio così.
-È davvero così stupefacentemente semplice.
Con candore tira fuori una jetable e ci scatta una foto, senza nemmeno inquadrare.
Il sole se ne è andato e fuori, nonostante la stagione, tira un vento gelido. Me ne vado via a piedi, con l’animo in subbuglio, con le foto negli occhi e i racconti dei ricordi di Marc Ribaud nel cuore. Me ne vado a testa bassa, guardandomi attorno appena, se non per fare qualche foto di quelle fatte con la mente, e godendomi la città e le sue genti nella sera che volge all’imbrunire.
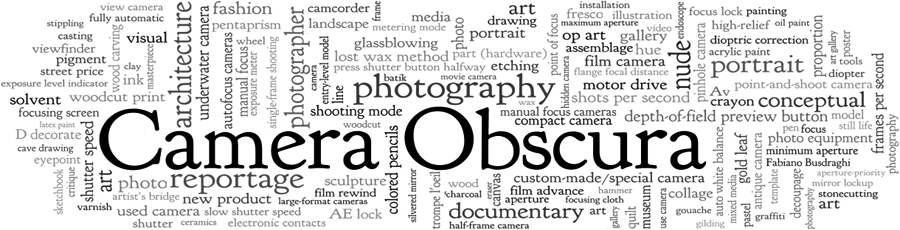














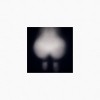












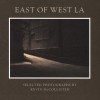






Puoi anche iscriverti al feed RSS dei commenti a questo articolo.